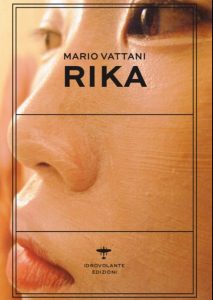Avendo appreso che con il nuovo anno L’Intellettuale Dissidente si trasformerà in una cosa nuova, ho voluto salvare dall’oblio, ospitandola sul mio sito personale, questa intervista realizzata il 29 giugno 2021 da Fabrizio Testa per quella testata. Non tanto per il suo titolo anche troppo lusinghiero, quanto per l’ampiezza dei temi trattati in quella conversazione che avevo molto apprezzato.
Intervista a Mario Vattani in occasione dell’uscita del suo nuovo romanzo “Rika”, di Fabrizio Testa – 29 giugno 2021
I suoi romanzi attraversano il sacro, tra underground e tradizioni. Mario Vattani è un audace interprete della letteratura italiana. Parole che tagliano le pagine come katane. L’urlo feroce d’una scrittura acuta, mai banale, sempre carica di segni e simboli. Uscito da poco per i tipi di Idrovolante Edizioni, Rika è l’ultimo romanzo di Mario Vattani che quasi chiude in un cerchio narrativo, ambientando la storia a Roma, quello che era cominciato a Tokyo nel primo scritto datato 2016. Una carriera da diplomatico parallela a quella di romanziere, attento osservatore del nostro tempo, esperto di arti marziali, esigente lettore.
La sua attività di romanziere la vede impegnato a partire dal 2016 con Doromizu. Acqua Torbida che esce per Mondadori. Seguono poi La via del sol levante (Idrovolante, 2017) Al Tayar (Mondadori, 2019) e l’ultimo Rika uscito quest’anno sempre per Idrovolante.
Nelle sue pagine, immerse tra ombre e luci ci sono le città giapponesi, con i loro confini, l’underground, le tradizioni. Mi racconta del suo ultimo scritto e della sua passione per questa terra?
Rika è uscito da poco più di un mese, quindi è come se la terribile avventura di quella ragazzina giapponese a Trastevere – avvenuta davvero nel 2011, e che ho sempre desiderato raccontare – stesse adesso circolando per conto suo, fuori dal mio controllo. A vederla così, mi accorgo che esiste un percorso in questi tre romanzi, e che è uno specchio della mia esperienza personale. Nel primo libro della trilogia, Doromizu, il protagonista è uno straniero a Tokyo, ma si muove liberamente in un mondo che il lettore impara a conoscere attraverso i suoi occhi. Nel secondo libro, Al Tayar, l’Egitto in cui si immerge Alex è sconosciuto a lui e a noi, e noi viviamo insieme al protagonista ogni sua sorpresa, ogni delusione, ogni innamoramento, ogni paura. Nel terzo libro, Rika, torniamo a Tokyo, e poi arriviamo a Roma, ma l’esperienza è completamente diversa, perché ora i pensieri sono giapponesi. Si chiude il cerchio con un cambiamento di pelle, e allora ecco che siamo di nuovo stranieri, ma stavolta a casa nostra. È il modo in cui ho conosciuto il Giappone, attraverso una serie di trasformazioni. Sempre con la sfida di ritrovarmi dietro le quinte, da unico straniero. A differenza di altri paesi in cui ho vissuto per via degli spostamenti della mia famiglia, la scelta del Giappone è stata mia, intima e personale, direi una scelta di vita. E’ stata frutto di una preparazione che ho iniziato anni prima di trasferirmi. Ero mosso da un innamoramento prima di tutto visivo: i colori, le linee, i contrasti, le regole della bellezza così diverse dalle nostre. Ho iniziato con lo studio della lingua, poi il kendo – e quindi tutto il mondo zen che vi ruota attorno – poi il cibo, i suoni, il ritmo dei movimenti, e poi naturalmente le amicizie, le donne, la fotografia, l’arte. Ogni volta so di essere stato una persona diversa, ogni esperienza mi ha modificato profondamente, perché la via del Sol Levante è una via severa, di disciplina e di preparazione, dove però non mancano il gioco, il piacere, anche la follia.
Sono sempre rimasto affascinato dalla tecnica dello scrittore. Artigiano della penna e della carta, tessitore di trame partorite molto spesso da una piccola intuizione iniziale. Hemingway scriveva in piedi otto ore al giorno salvo poi la mattina seguente eliminare gran parte del materiale. A tratti me lo ricorda. Nelle sue pagine c’è un ritmo asciutto, essenziale ma imponente. Qual è il suo metodo?
L’italiano non è la lingua con cui ho seguito i miei studi. La mia educazione è francese e inglese, per questo nello scrivere cerco di evitare le frasi troppo lunghe, di usare uno stile semplice. La mia cartina di tornasole è questa: riuscirebbe a leggerlo senza stancarsi anche uno straniero? Cerco un ritmo che non affatichi il lettore, voglio che segua le immagini, il dialogo, i profumi, la consistenza di ciò che lo circonda, non il ragionamento. Lavoro tantissimo sul testo, soprattutto sui dialoghi, forse la parte che mi diverte di più. Ho sempre un “libro del libro”, un quaderno pieno di appunti e calcoli dei tempi, il calendario, le distanze tra i luoghi, le mappe delle scene. Scrivo di notte, quando vedo le immagini che mi scorrono davanti agli occhi mentre le racconto. Poi mi fermo e taglio, il più possibile. Come nella musica, penso che anche nella scrittura si riesca ad ottenere un risultato più efficace attraverso la rarefazione, piuttosto che aggiungendo tracce su tracce. Non voglio descrivere le emozioni e gli stati d’animo, desidero invece portare il lettore a sentire lui stesso le emozioni, a causa della situazione in cui si trova. Nascondo nel testo dei trabocchetti e degli stratagemmi, perché il regalo più bello che mi può fare un lettore è rileggere questa o quella scena, come rivedere le scene preferite di un film. Quando ho un progetto, ci metto le mani tutti giorni, fosse anche solo per cambiare una virgola. Ogni capitolo ha più o meno la stessa durata, come la puntata di una serie televisiva, e cerco di fare in modo che ogni capitolo abbia anche un suo significato a parte, una sua morale. Ho cercato di seguire questo criterio anche scrivendo il mio saggio Svelare il Giappone pubblicato lo scorso anno da Giunti. L’obiettivo è sempre raccontare procedendo per immagini, facendo in modo che il lettore si distragga il meno possibile.
In un Italia dove tutti “scrivono” e pubblicano (addirittura cuochi, sportivi, vallette, papponi) ma in pochi, pochissimi leggono quale, secondo lei, il destino della narrativa e del mestiere dello scrittore? Ci sarà un ritorno alla buona scrittura e nasceranno nuovi Malaparte, nuovi Céline oppure siamo destinati irreparabilmente all’oblio letterario? Parlando sempre di narrativa, oggi secondo me leggere è ancora più importante di scrivere. Con quali autori si è formato e cosa legge oggi Mario Vattani?
L’avvento nefasto degli smartphone ha creato una situazione da cui penso che sarà impossibile tornare indietro. Il tempo che si trascorreva a leggere o a creare qualcosa è stato fagocitato da uno schermo luminoso che trasmette di solito sciocchezze. Ciò detto, confesso che anch’io, quando scrivo, mi rivolgo a lettori che vivono in questo mondo, che sono sempre connessi, e quindi si distraggono facilmente, in continuazione. Anche nel mio mestiere di diplomatico si scrive sfidando ostacoli simili. Il tempo è limitato, ogni politico ha fretta, occorre informarlo rapidamente, mantenere alta la sua attenzione. Probabilmente questo atteggiamento di fronte al foglio bianco ha un’influenza importante anche sullo stile con cui scrivo romanzi. E’ una lotta tra il lettore disattento e chi invece deve imbrigliarlo e tenerlo fermo sul sentiero del racconto. Personalmente, da molti anni non riesco più a leggere senza osservare o giudicare lo stile di chi scrive. Sono purtroppo diventato un lettore severissimo. La fortuna dell’educazione francese è che a scuola si passano molte ore ad analizzare i testi, il vocabolario, il ritmo. Amo i classici, ma mi rendo conto che in alcuni casi sono lontani dalle aspettative del pubblico moderno, e questo naturalmente non è bene. Fanno eccezione quei veri avanguardisti della scrittura, che non invecchiano mai, appunto perché non seguivano le regole nemmeno allora. Leggo molto in inglese e in francese, meno in italiano. Sono cresciuto con Roald Dahl, Anthony Burgess, Dickens, Conrad. Amo lo stile asciutto di Hemingway e di Albert Camus. Una generica delusione e una visione non molto positiva del futuro mi portano a volte a distrarmi con il grande Wodehouse. Ultimamente, tramite Houellebecq ho scoperto Huysmans, che mi ha colpito enormemente per la sua abilità senza tempo di costruire immagini, atmosfere e descrizioni, e in un certo senso lo sto “studiando”.
Forse uno dei motivi di questo spaesamento culturale è il massivo innesto della rete nelle nostre vite come buco oscuro e risucchiante. Portali quali Amazon (o le varie piattaforme musicali e cinematiche) con la scusa di divulgare cultura ed intrattenimento, accecano il fruitore inesperto verso scelte poco coraggiose in linea con il pensiero unico. Soprattutto per i giovanissimi che non hanno vissuto, contrariamente a noi, l’era delle scoperte e del mondo analogico oggi sembra più difficile di ieri elaborare un proprio pensiero critico, trovare così il proprio percorso, il proprio gusto nella letteratura, nel cinema, nella musica. Ci sarà pur un modo per arginare questa inquietante intrusione prima che sia troppo tardi?
È vero. Ho l’impressione che le generazioni nate dopo l’avvento della rete siano abituate a una massa di informazioni in gran parte inutili, che vengono sempre elaborate da qualcun altro, semplificate e presentate come già risolte. Noto una generale assenza di senso critico, un tentativo costante di emulare, di imitare. Anche la ribellione viene impacchettata e servita secondo forme già elaborate e precotte. All’inizio pensavo che in fondo anche la nostra adolescenza era così, ma con mezzi diversi, però adesso sto accorgendomi che non è così. Assisto a comportamenti gregari di cui non mi ero mai accorto prima. Il conformismo travestito da rivoluzione è ormai la condizione normale di tantissimi giovani.
Ho smesso di essere ottimista sul futuro. Certo, rimangono percorribili delle soluzioni individuali, che in fondo sono sempre esistite. Le discipline, le “vie”, lo sport, l’apprendimento, lo sforzo per migliorarsi, attività che aprono lo sguardo su mondi reali e nel contempo interiori, che rappresentano una validissima alternativa al buttare via il proprio tempo – e quindi la propria vita – attaccati a uno smartphone.
Tornando al Giappone e alle sue tradizioni ho scoperto che lei è anche un appassionato di arti marziali. Pratica infatti, da parecchi anni, il Kendo. Pur avendo praticato arti marziali completamente differenti, il Kendo in particolar modo mi ha sempre affascinato. C’è dentro il sacro, la battaglia, la gestualità dell’attacco come preludio al silenzio. Mi racconta i suoi esordi nella disciplina, le differenze della pratica tra l’Italia e il Giappone e come è cambiato rispetto allo sdoganamento iniziale della pratica nel nostro continente nei tardi anni sessanta?
Il kendo è stata la chiave di accesso per il mio Giappone. Ho iniziato a praticarlo negli Stati Uniti, il nostro sensei era l’allenatore della squadra USA di kendo, un maestro di altissimo livello, Shozo Kato. Mi ritengo fortunato ad averlo conosciuto. Il kendo ha avuto un’influenza fondamentale sulla mia vita, fin nei minimi dettagli, anche nel modo in cui preparo una valigia o prendo una decisione importante. Quando iniziai mi allenavo tre volte a settimana e non perdevo mai un seminario nel weekend. Alla fine di ogni allenamento ero un’altra persona, avevo imparato qualcosa di me stesso, non sempre positivo o rassicurante. Nel frattempo vedevo decine e decine di film giapponesi, leggevo saggi sullo zen, libri di storia nipponica. Era come se volessi recuperare un tempo perduto, un’altra vita. Mi interessano comunque tutte le arti marziali, anche quelle occidentali. Ultimamente ho iniziato a praticare la scherma storica e mi trovo molto a mio agio, perché il rapporto con i movimenti, con il vocabolario e con la cultura è più diretto, non ho l’ostacolo di dovermi continuamente adeguare ad un’altra impostazione culturale.
Un’ultima domanda, che sfiora il sacro. Una delle cose che più mi inquietano e mi affascinano durante il continuo presente che frequento è la paura della morte, il disfacimento di chi mi sta intorno, la forte certezza che tutto dovrà scomparire. Un ultimo pensiero, prima di congedarla, è su questo tema.
Penso che la coscienza della morte sia la nostra più grande fortuna, perché ci pone di fronte al vuoto, e continua a canzonarci ripetendoci che tutto è inutile, che tutto finirà, noi, i nostri figli, il pianeta, anche le forze che governano il mondo, anche gli dei, e quindi tutto ciò che facciamo, scriviamo, costruiamo, è inutile. Così, di fronte alla morte siamo costretti a farci la domanda più vecchia del mondo: qual è allora il significato della vita? La risposta, almeno per me, è immediata. Noi siamo qui per migliorarci, per seguire la strada che abbiamo scelto, per vincere la nostra pigrizia, per vincere le nostre paure, per dimostrare correttezza, coraggio, stile. Siamo qui per costruire e per opporci a chi distrugge, senza mai arrenderci. E poi per morire, scomparendo nel buio. Ma va bene così.